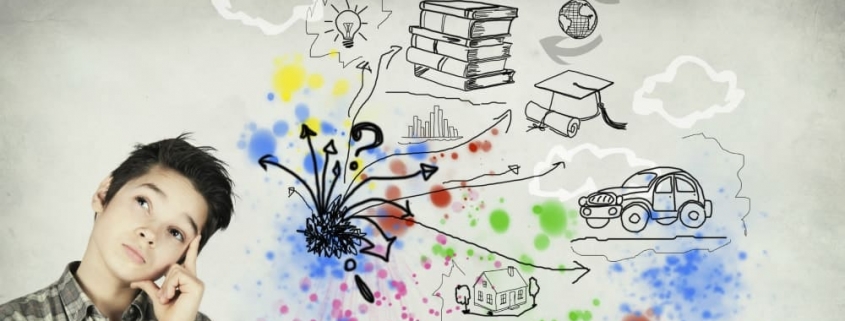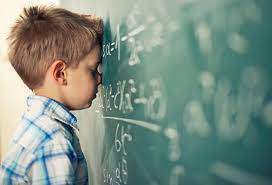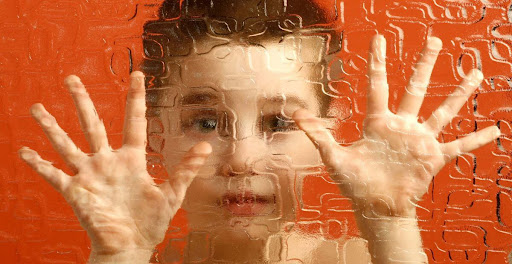Il linfedema consiste in un rallentamento della circolazione linfatica e venosa per cause di varia natura, che si possono riconoscere come primarie o secondarie. Le cause primarie sono rappresentate da anomalie congenite del sistema linfatico morfologiche o funzionali. Il linfedema è una patologia cronica e progressiva che può essere già presente alla nascita ma spesso può manifestarsi in età più o meno avanzata.
Talvolta si può riconoscere una causa scatenante quale una bruciatura cutanea, una puntura di insetto o altro. Si suppone che il sistema linfatico già compromesso dall’anomalia genetica non riesca a compensare l’edema causato dall’evento scatenante, vada in sovraccarico funzionale e manifesti ciò che era comunque già presente seppur non ancora manifesto. Cause secondarie per eccellenza sono gli interventi chirurgici con asportazione linfonodale. Il rischio di sviluppare un linfedema aumenta se viene associata radioterapia. Altre cause secondarie sono rappresentate da traumi di qualunque genere, infezioni o farmaci edemigeni, in questi casi l’edema è solitamente transitorio e il linfodrenaggio favorisce una guarigione maggiormente rapida. Dal momento che il sistema linfatico e quello venoso non possono anatomicamente essere considerati come completamente separati essendo per conformazione simili seppur non uguali, in caso di insufficienza venosa con edema degli arti, il linfodrenaggio, la pressoterapia e l’idrokinesiterapia potrebbero fornire un utile supporto terapeutico. Il lipedema è una malattia progressiva che si manifesta quasi esclusivamente nel sesso femminile. E’ caratterizzato da un accumulo atipico di tessuto adiposo. La donna con lipedema manifesta la tendenza a procurarsi lividi con facilità e percepisce come dei piccoli noduli sottocutanei. In fase avanzata tende a sentire dolore, calore e pesantezza agli arti. In questi casi il linfodrenaggio e la pressoterapia non sono ad oggi le terapie per eccellenza ma risultano attivi coadiuvanti nelle fasi iniziali e un efficace aiuto per il miglioramento della sintomatologia dolorosa. Il drenaggio linfatico manuale è una delle tecniche utilizzate in quella che viene definita Terapia Decongestiva Complessa ad oggi considerata il trattamento d’eccellenza per i problemi linfovenosi. Della terapia decongestiva complessa fanno parte tecniche quali:
• drenaggio linfatico manuale
• bendaggio multicomponente
• terapia elettromedicale coadiuvante
• cura della cute
• utilizzo di calze o bracciali elastici
• pressoterapia
• percorso vascolare
• esercizio fisico
• controllo del peso corporeo